SULLA PRESENZA: riflessioni per un’integrazione tra Mindfulness e Gestalt
Abstract
Di Pierluca Santoro – Didatta IGF – Psicoterapeuta e Istruttore Mindfulness
Pubblicato sul numero 41 di Formazione IN Psicoterapia, Counselling, Fenomenologia
Abstract: Il concetto di presenza mentale, derivato dalle pratiche meditative buddhiste, intreccia in occidente sia la cosiddetta Mindfulness che la Psicoterapia della Gestalt. L’articolo cerca di mettere in luce alcune delle traduzioni filosofiche che hanno portato alle attuali declinazioni della meditazione sapienziale nelle esperienze terapeutiche e nelle pratiche di consapevolezza, mettendo l’accento sui punti di convergenza e su alcune contraddizioni.
Parole chiave: presenza mentale, mindfulness, Gestalt, consapevolezza.
Quando sono stato in Thailandia per la prima volta ero alla ricerca di pace. Una pace interiore che avevo perso a causa delle infinite tribolazioni della vita che conducevo e da cui non riuscivo a estrapolare un senso pur essendo già da tempo uno psicoterapeuta. Ero lì per motivi professionali, insieme a Paolo Quattrini e Valentina Barlacchi, molto distanti da quelli che successivamente avrei rintracciato nell’arco delle esperienze successive. Dovevamo fare un corso di formazione ai monaci di un’università buddhista vicino Bangkok sui temi della psicologia occidentale e in particolar modo della psicoterapia e, da bravi gestaltisti, non avevamo concordato praticamente nulla in termini di programma didattico. Ci si sarebbe buttati nell’esperienza come sempre con il nostro bagaglio professionale e umano e avremmo accettato di buon grado quello che l’incontro con quegli studenti ci avrebbe portato. Paolo in realtà era da anni che faceva su e giù dalla Thailandia e, senza confessarmelo apertamente, aveva un’idea molto chiara della cultura nella quale si sarebbe immerso per l’ennesima volta. Io no. Ero lì con la mia curiosità, la mia paura e la mia incrollabile speranza che l’insicurezza non mi avrebbe ucciso del tutto. Tanto c’erano lui e Valentina e, male che andasse, mi sarei nascosto sullo sfondo come spesso faccio quando la paura diventa intollerabile. Ma il mio desiderio recondito di quel viaggio, in realtà, non era certamente la didattica. Un po’ per caso e un po’ per sfida, infatti, mi sono ritrovato a intraprendere un viaggio cha ha cambiato la mia vita e che mi ha dato modo di toccare, forse per la prima volta, quella che i buddhisti chiamano la presenza mentale.
Finito il seminario che avevamo tenuto, a colloquio con uno dei monaci che lo aveva seguito e che si era dimostrato particolarmente interessato al senso che noi davamo delle emozioni e delle loro espressioni, chiesi timidamente quale potesse essere una buona occasione per apprendere i rudimenti della meditazione che loro praticavano (all’epoca sapevo a malapena cosa fosse la Vipassanā e il buddhismo Theravada) e se conoscesse un luogo o un insegnante a cui potessi rivolgermi. Sapevo che andavano parecchio di moda, proprio e soprattutto in Thailandia, dei ritiri di meditazione per stranieri nei vari templi buddhisti da nord a sud del paese, ma non mi fidavo granché avendo parecchi pregiudizi in merito a tutte le derive new-age del nostro continente e l’idea che anche lì, uno dei paesi che campa di turismo occidentale praticamente in ogni sua manifestazione culturale, avrei potuto incontrare un’esperienza un po’ stereotipata o poco significativa. La fortuna fu proprio, al contrario, quella di avere di fronte a me un maestro di meditazione per i monaci Theravada, che il giorno dopo sarebbe partito verso il sud per cominciare un ritiro di formazione di dieci giorni in un posto imprecisato (la lingua thailandese, parlata e soprattuto scritta, si avvicina molto a quella che comunemente chiamiamo ostrogoto…), e che mi invitava ad andare con lui, a ricevere l’insegnamento “corretto” e originario. Mi fidai. E partii con lui.
Immerso nella giungla, e circondato da un centinaio di monaci, ho appreso i rudimenti di quella pratica che in Thailandia ha un forte connotato spirituale e religioso, la meditazione Vipassanā (in lingua pali. In sanscrito, Vipaśyanā) e che, come abbiamo visto, nel mondo occidentale è scambiata erroneamente come Mindfulness.
Dalla psicologia bubbhista alla Mindfulness e ritorno
Mindfulness è la traduzione occidentale (in inglese) di una parola e di un concetto che in lingua pali (dialetto, o volgare, parlato all’epoca del Buddha in alcune zone dell’India e alternativo al sanscrito che invece era considerata la lingua della letteratura, e quindi di chi sapeva appunto leggere e scrivere) corrisponde a SATI e vuol dire, sintetizzando, presenza mentale, consapevolezza o ancora pratica dell’attenzione consapevole.
Il Satipaṭṭhāna sutta, il celebre discorso del Buddha sui quattro fondamenti della presenza mentale o consapevolezza, è alla base di questa pratica meditativa, che sta rivelando potenzialità applicative sorprendentemente vaste ai problemi della vita contemporanea.
Più specificatamente, la mindfulness, o pratica dell’attenzione consapevole, è un termine che è cominciato a circolare negli anni sessanta quando i viaggi di esplorazione della cultura orientale avevano preso pieno ritmo anche in quello occidentale ed è forse a Tich Nath Han, monaco buddhista vietnamita, che va dato il merito di averlo usato e divulgato maggiormente. In anni successivi, oltre all’utilizzo del termine da parte di tutti gli insegnanti di Dharma in ogni luogo del mondo come ad esempio Joseph Goldstein che così ha intitolato il suo compendio principale (Goldstein J., 2013), pratiche basate sulla mindfulness hanno cominciato ad essere sviluppate in ambito clinico e terapeutico negli Stati Uniti ed è per merito di Jon Kabat-Zinn, ad esempio, che si sono diffusi i protocolli di utilizzo per la riduzione dello stress come l’MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) o quelli per la depressione come l’MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy).
Tuttavia, molto spesso semplificando, la mindfulness è stata associata alle pratiche di meditazione Vipassanā, diffuse in oriente e in particolar modo nelle tradizioni buddhiste Zen e Theravada. In realtà, la meditazione Vipassanā, di cui ormai esistono moltissime esperienze intensive anche in occidente, è una pratica più complessa e profonda che non si riduce all’addestramento dell’attenzione consapevole. Vipassanā infatti è una parola che può essere tradotta, seppur superficialmente, con “visione profonda” o insight meditation (in inglese), ed è una pratica che presuppone diversi passaggi tra cui quello caratteristico della mindfulness che è Śamatha, ovvero l’osservazione del respiro, del momento presente e la calma concentrazione (Samādhi). Ma se Śamatha può essere raggiunta attraverso quella che nel Canone Pali (la prima raccolta degli insegnamenti verbali del Gothama Buddha) è descritta nell’Ānāpānasati Sutta (ovvero l’insegnamento su come si pratica sul respiro), Vipassanā, lo stato più profondo di visione e contatto con l’impermanenza della realtà per la liberazione dalla sofferenza, può avvenire successivamente attraverso la contemplazione prolungata degli oggetti mentali. E questo richiede uno sforzo, una disciplina e una costanza di attenzione prolungate nel tempo e nella pratica.
Nel tentativo di riassumere alcuni dei concetti buddhisti più importanti, possiamo fare riferimento alla dottrina del Buddha storico del famoso “Discorso di Benares”, in cui vengono esposte le Quattro Nobili Verità.
Nella prima Nobile Verità si afferma che “tutto è dolore”, o meglio che l’esistenza è segnata da una continua esperienza dolorosa, che la realtà è caratterizzata dall’impermanenza – cioè che tutto, dalle persone, alle cose, ai sentimenti, è destinato a dissolversi – e che non esiste l’io, cioè un principio immanente di individualità. E questo è di importanza capitale per poter distinguere la cultura buddhista da quella di tutte le altre religioni del mondo, per il semplice fatto che venga stravolto il concetto di assoluto e quindi di divino e di anima che trascende l’esistenza.
La svalutazione sistematica del rito, la negazione di un dio personale e di un sé immutabile, erano cose inaccettabili per i devoti induisti, coinvolti in tantissimi riti, e che dell’esistenza di un sé immutabile, o atman, facevano un caposaldo della tradizione. In più il Buddha, sebbene di nobile stirpe, proponeva l’uguaglianza degli esseri e accettava chiunque nella propria comunità, incontrando non poche critiche da parte degli induisti ortodossi, separati rigidamente dalle caste, e secondo i quali solo i sacerdoti e i guerrieri potevano dedicarsi a una vita religiosa. Il Giainismo – scuola eterodossa sistematizzata quasi nello stesso periodo del Buddhismo – era invece contrario al libero arbitrio sostenuto dal Buddha.(Girolami, 2020)
Nella seconda Nobile Verità si afferma che l’origine della sofferenza è la sete, l’attaccamento e l’avversione. In altre parole, bramiamo ardentemente ciò che ci piace e avversiamo ed evitiamo ostinatamente ciò che non ci piace. Ma, essendo la realtà impermanente, un po’ come nella tradizione eraclitea del panta rei, anche le esperienze piacevoli hanno un termine, le persone amate scompaiono, gli oggetti si rompono, e quello che ci rimane è la perdita o il contatto con lo spiacevole. La non accettazione di questa inevitabile condizione esistenziale non fa che aumentare il dolore esistenziale. La terza Nobile Verità tuttavia fornisce una speranza, cioè quella che è possibile estinguere questa insoddisfazione, questa brama egoistica e raggiungere il Nirvana, la liberazione. Nella quarta Nobile Verità, infine, il Buddha Shakyamuni ci mostra quindi la Via per raggiungere tale liberazione, l’Ottuplice Sentiero, che può essere riassunto in tre semplici punti: lo studio e la profonda comprensione degli insegnamenti, il comportamento etico, e la pratica della meditazione.
Tuttavia occorre comprendere che gran parte dell’insegnamento del Buddha è dedicato proprio alla meditazione, lo strumento principale per la realizzazione della liberazione. In Occidente con “meditazione”, o meditatio, di solito s’intende il pensare, il riflettere su un passo delle sacre scritture per giungere a una più profonda comprensione di esse. Ma in ambito buddhista il termine sanscrito che indica le pratiche ascetico-concentrative è bhavana, dalla radice verbale bhu, o “essere”. Bhavana, pertanto, può essere tradotto come “esserci”, esserci di più, ora. Dunque la pratica contemplativa buddhista non deve rimandare a una cogitazione continua, bensì all’essere totalmente calati nel momento presente, all’essere completamente consapevoli di se stessi, del proprio corpo, dei propri pensieri e così “cogliersi in fallo” quando si dà vita a quel meccanismo di attaccamento mentale ed egoico che, in ultima analisi, porta alla sofferenza esistenziale. In tal modo è possibile raggiungere la liberazione e divenire come il Buddha, l’illuminato, colui il quale è completamente sveglio, totalmente consapevole. (Ibidem)
Come sottolineato da Dario Doshin Girolami, ecco qui una lettura interessante di quella traduzione semantica compiuta in occidente sia nella parola meditazione che in quella di mindfulness, dove nella prima possiamo rintracciare il concetto di “ritorno”, di “riconoscimento” della realtà o di ricordarsi, e nella seconda di “esserci”, di presenza appunto, altro concetto che più avanti collegheremo inevitabilmente a quello di dasein husserliano.
Se partiamo dal presupposto buddhista, la prima Nobile Verità, che la vita sia fondamentalmente dukkha, cioè insoddisfazione pervasiva o, come viene tradotta comunemente, sofferenza, la meditazione serve a riportarci e ricordarci il momento presente e a dis-identificarci da tutti condizionamenti e gli attaccamenti che quotidianamente e culturalmente ci portano a soffrire per quello che non abbiamo o abbiamo perso o bramare quello che non potremo mai ottenere. La visione profonda sta nell’accorgersi di questa sofferenza indotta dall’attaccamento alla materialità della vita e dall’ignoranza in relazione al mondo e al suo manifestarsi (avidyā, sans., avijjā, pāli), nell’accettazione dell’impermanenza di ogni cosa (anitya, sans., anicca, pāli), che nasce e muore continuamente così come ogni cellula del nostro corpo, e nel ritrovare una pace interiore in interconnessione con il mondo e le persone che lo abitano. Qui e ora.
In questa prospettiva, l’interconnessione e l’interdipendenza di tutte le cose che appartengono al mondo, uno stato di consapevolezza che parte dal respiro e dal corpo individuale e si estende a tutti i fenomeni circostanti, è la base per lo sviluppo di saggezza (in sanscrito prajñā, in pāli paññā, fatta di retta visione e retta intenzione) ed etica (sanscrito śīla, pali sīla, costituita da retta parola, retta azione e retto mestiere). Saggezza, etica e meditazione (parti essenziali di quell’Ottuplice Sentiero che il Buddha indica come il percorso per il risveglio interiore) necessitano dello sviluppo e del sostegno di una comunità (saṅgha) consapevole dell’interdipendenza di ciascun elemento della realtà (saṃsāra), ed è per questo che le pratiche meditative hanno più valore se ricondotte a una dimensione gruppale e si differenziano per scopi e tecniche rispetto ai protocolli clinici come l’MBSR, che invece riduce consapevolmente la meditazione al raggiungimento di scopi individuali quali la riduzione dello stress o del dolore.
Se la consapevolezza quindi rimane lo scopo principale della mindfulness e della meditazione, l’integrazione con la psicoterapia di stampo occidentale, soprattutto quella gestaltica, allarga e integra il campo al cambiamento personale e allo sviluppo della responsabilità individuale. Se la meditazione è come un cuneo che interviene tra la realtà così come è e la sua percezione (vedanā), allargando lo spazio della consapevolezza al libero arbitrio nel qui e ora, svincolato dai condizionamenti e dagli attaccamenti a passato e futuro, la psicoterapia è il contenitore dello sviluppo di quel libero arbitrio che favorisce la responsabilità di un nuovo agire nelle relazioni interpersonali e il soddisfacimento di nuovi bisogni e desideri più in contatto con la realtà che con le aspettative illusorie.
Ma a cosa si riferisce dunque questo “esserci”, la presenza mentale, o la consapevolezza, nella psicologia buddhista e come è stata tradotta nella mindfulness nelle sue molteplici sfaccettature applicative?
In inglese c’è una parola che traduce consapevolezza ed è awareness, nonostante questo è stato scelto di tradurre il concetto buddhista con mindfulness, che in italiano potremmo a nostra volta tradurre con “il pienamente mentale” o la “pienezza mentale”. Sta di fatto che, a prescindere dalle traduzioni linguistiche il concetto di presenza richiama qualcosa che a mio avviso può essere ricondotto a quello di “testimonianza” e, inevitabilmente, a quello di attenzione. Ma testimonianza e attenzione a cosa esattamente? Inevitabilmente a ciò che ci ricorda, continuamente, che siamo vivi, e cioè il nostro corpo nello spazio. A partire da quell’elemento imprescindibile che è il respiro, fonte principale del nostro metabolismo che è il sistema di scambio e relazione con il mondo esterno e il mondo interno. La mente per i buddhisti è questo processo di scambio ed elaborazione in senso olistico, non solo o propriamente l’organo cervello. Non a caso, se si incontra un orientale, quando indica la mente lo si può vedere toccarsi il petto, il centro del corpo o il cuore, e non la testa come potremmo fare noi occidentali.
Tornando quindi alla mindfulness e all’uso che se ne fa in Occidente rispetto alla sua provenienza sapienziale, possiamo notare alcune specificazioni proprio rispetto al concetto di presenza mentale. Nell’Ottuplice Sentiero indicato dal Buddha, che come si è visto in precedenza configura la quarta Nobile Verità ovvero il percorso necessario a giungere alla liberazione dalla sofferenza e al Nirvana, si fa riferimento a:
Retta Comprensione (samma ditthi): la conoscenza dell’insegnamento del Budda, vedere la realtà così come è.
Retta Motivazione (samma sankappa): o retta intenzione, come oriento la mia azione, il mio studio, la tensione verso.
Retta Parola (samma vaca): il mio parlare deve essere un parlare veritiero gentile appropriato benefico.
Retta Azione (samma kammanta): come la parola deve manifestare la saggezza.
Retta Vita (samma ajiva): anch’esso deve manifestare saggezza.
Retto Sforzo (samma vajama): quanto ci costa svegliarci la mattina per fare meditazione? Non esiste spontaneamente, richiede una intenzione.
Retta Consapevolezza (samma sati): mindfulness, la presenza mentale.
Retta Concentrazione (samma samadhi): è l’assorbimento meditativo.
Ognuno di questi fattori è preceduto dall’attributo retto, che in sanscrito è samiak/samma. Raggruppati a tre e a tre, eccetto gli ultimi due, i fattori dell’Ottuplice Sentiero configurano saggezza (il primo, prajñā, costituito da Retta comprensione, motivazione e parola), etica (il secondo, śīla, costituito da Retta azione, vita e sforzo) e meditazione (il terzo, samadi, costuito da Retta consapevolezza e concentrazione).
Essendo una prospettiva spirituale, il buddhismo ovviamente abbraccia un’idea dell’essere umano che comprende tutti gli aspetti dell’esperienza esistenziale. Per la liberazione o l’illuminazione, non basta quindi solo lo studio e la motivazione, ma si deve tradurre il comportamento in una azione eticamente sensata, e in una contestuale e costante pratica di meditazione di consapevolezza; solo dalla compresenza di questi tre elementi si può andare verso la liberazione dalla sofferenza. Ciascun elemento sostiene l’altro, e le tre dimensioni operano in sinergia. L’attenzione o la presenza mentale (sati/smriti), quella che in occidente è stata tradotta in italiano come presenza mentale ed in inglese come mindfulness da sola non è sufficiente.
È stato visto in precedenza come la parola meditazione sia stata usata per tradurre la pratica buddhista finalizzata alla consapevolezza, ed è interessante notare come i passaggi linguistici ed etimologici spesso siano riconducibili a semantiche per certi versi analoghe ma non omogenee. Smriti in sanscrito ha la radice Smr che si può tradurre con ricordo; ma ricordarsi di cosa? Di stare nel momento presente, di fare meditazione. In italiano la parola ricordo è bella perché viene dal latino recordo = dare il cuore, che per gli antichi era sede della memoria. Traslando e dando senso ai riferimenti linguistici quindi potremmo dire che la pratica è un dare il cuore (ovvero memoria) alla realtà del momento presente. Questa è l’essenza della pratica, l’essenza della mindfulness, uno stare nel momento presente rimembrando, dando vita al momento presente con le nostre membra (da cui anche rimembrare). Non essendo in pace con il momento presente, neghiamo la sua presenza, mentre la mindfulness permette di restituire questa vita al momento presente. La mindfulness nell’Ottuplice Sentiero è quindi retta mindfulness, che vuol dire che la presenza mentale è retta se funziona in sinergia con gli altri sette elementi. Se la estrapolo dall’insieme di cui è parte e che contribuisce a creare nell’esperienza, non funziona. Jon Kabat Zinn, da bravo biologo molecolare, si fregia di aver individuato il “principio attivo” della tradizione: una presenza mentale che, per motivi evidentemente funzionali all’esportazione e alla comprensione occidentale, soprattutto non spirituale, del sentiero di liberazione buddhista che può essere amministrata meglio da un punto di vista teoretico e, soprattutto, da quello scientifico che, tradizionalmente, è considerato il campo dell’evidenza e della laicità. Ma la separazione dai restanti elementi dell’Ottuplice Sentiero è il punto critico che spesso rende la mindfulness occidentale una pratica ridotta a mera tecnica, più che a contenitore di esperienze esistenziali profonde. Questa è la critica che il buddismo muove, ad esempio, al protocollo MBSR. I tre elementi: saggezza, etica e meditazione occorrono tutti e tre, sono inseparabili. Protocolli basati sulla Mindfulness vengono proposti nei più diversi contesti proprio per la sua dimostrata efficacia nello sviluppo dell’attenzione, e associati al trattamento di diversi disagi psicologici come appunto lo stress, la depressione, i disturbi alimentari ecc, ma anche, ad esempio, dai cecchini dell’esercito USA affinché siano più concentrati per uccidere. In questo caso la mindfulness diventa pericolosa. Si insegna Mindfulness alle persone che lavorano in Borsa, si offrono corsi di mindfulness ai dipendenti di Google, multinazionale del profitto che è ubicata (giusto per fare un esempio di una contraddizione) in un quartiere dove vivono molti senza fissa dimora. Su cosa poggia, in questi casi, lo sviluppo di un atteggiamento mindful? Un altro modo di affermare ciò è: è vero che la meditazione è il motore di una macchina ma l’etica sono le ruote (traduco la mia consapevolezza in azione sensata), e la saggezza il volante (oriento il mio andare); nella prospettiva buddista è fondamentale che la meditazione lavori in sinergia con saggezza ed etica. Così come la presenza mentale richiede un training lungo e specifico, allo stesso modo lo sono le altre dimensioni.
La mindfulness e l’MBSR aiutano le persone “tecnicamente”, cioè le aiutano a ripristinare la fisiologia e la funzionalità esistenziali. Aprono le porte di una percezione di se stessi nuova e per certi versi utile al ripristino degli equilibri psicofisici di un individuo immerso nel flusso dell’esperienza di vita. In una società della performance, in cui la tecnica ha preso il sopravvento sulla spiritualità, dove saper fare è più importante dello scopo stesso del fare e delle sue finalità etiche, dove produrre e collaborare per farlo diventano valori necessari alla sopravvivenza sociale e psicologica, queste pratiche diventano strumenti contraddittori e alla lunga controproducenti alla qualità della vita intesa come accrescimento dell’etica, dell’estetica e della logica del vivere comune, che invece avrebbe bisogno di una trasmissione del sostegno sul piano democraticamente creativo e su quello valoriale.
Conviene a questo punto citare Stephen Batchelor, maestro di dharma e autore di pregevoli testi sul buddhismo e la sua evoluzione contemporanea:
Quale tipo di buddhismo sostiene un buddhista che si dichiara, come me, laico? Non ho in mente un buddhismo che cerchi di mettere da parte ogni traccia di religiosità, che cerchi di arrivare a un dharma che è poco più di un insieme di tecniche di auto-aiuto che ci permettano di operare in modo più calmo ed efficiente come agenti e/o clienti del consumismo capitalistico. Potremmo sostenere che la pratica della consapevolezza, estrapolata dal suo contesto originario, di fatto rinforza l’isolamento solipsistico di sé immunizzando i praticanti dalle emozioni, gli impulsi, le ansie e i dubbi destabilizzanti che assalgono i nostri fragili io. Invece di immaginare un dharma che erige barriere ancora più solide attorno a un sé alienato, immaginiamo un dharma che opera verso un reincantamento del mondo. A tale scopo occorre coltivare una sensibilità verso ciò che si potrebbe chiamare il “sublime quotidiano” […]. (Batchelor, 2015. Pag. 23)
Intersezioni e integrazioni
Le matrici del concetto di presenza mentale nel buddhismo sono rintracciabili, quasi pedissequamente, anche nella psicoterapia della Gestalt (da ora in poi PdG) fondata da Fritz Perls negli anni 50.
Perls, mettendo in evidenza l’importanza di una relazione terapeutica centrata sul qui e ora sia per il terapeuta che per il paziente, definisce un concetto che chiama “continuum di consapevolezza”(Perls, Hefferline & Goodman, 1971). È l’esercizio di base della consapevolezza, strumento a disposizione del terapeuta per monitorare se stesso e l’interazione terapeutica e anche il risultato ideale cui tende la PdG. Serve a mettere in evidenza dove tende a soffermarsi prevalentemente l’attenzione — sia del terapeuta sia del paziente — e quali parti della possibile esperienza sono invece, in alcuni casi, accuratamente evitate. Come si diceva in precedenza, è tendenza naturale dell’essere umano quella di evitare il dolore e il pericolo e di mettere in pratica dei meccanismi di sopravvivenza che portano a reagire istintivamente sia al primo che al secondo. Ci sono dei veri e propri programmi neurobiologici, nel nostro organismo, che ci permettono di reagire “fisicamente” e prontamente al dolore e al pericolo attraverso comportamenti di attacco e di fuga. Ma se questi programmi sono fondamentali alla sopravvivenza nella realtà della presenza materiale, più complesso diventa il discorso sull’amministrazione dei dolori e dei pericoli in termini psicologici, cioè quando gli stimoli sono pensati e/o immaginati o ricordati. In altre parole anche quando tali stimoli sono rappresentati non tanto da oggetti fisici, ma quando i dolori e i pericoli sono configurabili all’interno di relazioni umane e affettive che richiedono una maggiore complessità di risposta oltre a quella riflessa o automatica.
Lo sviluppo della presenza, quindi, e di quello che Perls chiamava “continuum di consapevolezza”, richiede un atteggiamento e, per certi versi, delle tecniche di focalizzazione dell’attenzione molto simili a quelle della meditazione e della mindfulness. Ad esempio: mantenere il senso della realtà, la coscienza del fatto che la consapevolezza esiste qui e ora;
cercare di rendersi conto di come si vive l’esperienza, di come si agisce, si osserva, si soffre e si resiste a questa sofferenza;
prestare attenzione a tutte le esperienze “interne e a quelle esterne, quelle astratte e quelle concrete, quelle che tendono verso il passato e quelle che tendono verso il futuro”, quelle per cui sentiamo un dovere, quelle che semplicemente sono, quelle che intraprendiamo deliberatamente, quelle che sembrano avvenire spontaneamente. Celebre la frase suggerita da Perls nelle sue sedute, da pronunciare durante ogni esperienza: “Ora sono consapevole che… (Perls et al., 1971, pag. 100)
Il percorso di addestramento e crescita di un gestaltista prevede quindi lo sviluppo di questa attenzione fluttuante nella relazione con l’altro, di questa presenza a sé e di fronte all’altro e la capacità di sostenere il vuoto che si genera quando si interrompe il circuito automatico della reattività. È un atteggiamento mindful, di fatto, come spesso viene chiamato in altri approcci, ma che traduce il medesimo processo di sviluppo della consapevolezza, con la differenza che l’oggetto di attenzione si concentra non solo su se stessi ma anche sulla relazione con l’altro e su quello che si genera nel mezzo: una sorta di apertura al campo esperienziale, nel qui e ora, fatta di accettazione, sospensione del giudizio e indifferenza interpretativa. In altre parole, potremmo definirlo un atteggiamento mentale, o una qualità di presenza, che favorisce l’indipendenza dalle ripetitività delle dinamiche intrapsichiche, sia quelle del paziente che del terapeuta, e una maggiore libertà espressiva nel passaggio alla trasformazione richiesta dal percorso di crescita individuale.
Quello gestaltico, essendo un modello costruito a partire dal concetto che è il terapeuta stesso ad essere soggetto di presenza nella relazione, che non delega alla teoria o alla tecnica lo sviluppo di dinamiche trasformative in quanto fondamentalmente processo esperienziale e non teoretico, presuppone un lavoro di crescita centrato sulla presenza, sulla consapevolezza e quindi sulla responsabilità.
Bibliografia
Baer, R. A., & Maffei, C. (Eds.). (2012). Come funziona la mindfulness: teoria, ricerca, strumenti. Cortina.
Batchelor S., Dopo il Buddhismo, Astrolabio Ubaldini Editorre, Roma, 2015
Damasio A. R., (2004). L’errore di Cartesio: emozione, ragione e cervello umano. Adelphi.
Epstein M. Pensieri senza un pensatore, Astrolabio, Roma 1996.
Epstein M. Buddha, Freud e il desiderio, Indiana Editore, Milano 2012.
Frambach L. (2003) The Weighty World of Nothingness: Salomo Friedlaender’s “Creative Indifference”. In: Lobb M.S., Amendt-Lyon N. (eds) Creative License. Springer, Vienna.
Galimberti, U. (2002). Psiche e techne: l’uomo nell’età della tecnica (Vol. 12). Feltrinelli Editore.
Girolami D.D., Lo zen Soto e i Koan. La via della presenza di spirito, La Parola, 2014.
Girolami D.D., I discorsi del Buddha – Sutta Pitaka, (2020) http://www.romazen.it/insegnante/SuttaPitaka.htm
Goldstein, Joseph. Mindfulness: una guida pratica al risveglio. Ubaldini, 2013.
Goleman D., (1977): “Esperienze orientali di meditazione“, Milano 1982.
Kabat-Zinn J. Vivere momento per momento, Corbaccio, Milano 2004.
Naranjo C., Ornstein R.E. On the Psychology of Meditation, Viking, New York 1972.
Naranjo C., Atteggiamento e prassi della terapia gestaltica, ed. Melusina, Roma, 1991
Naranjo C., La via del silenzio e la via delle parole, Astrolabio, Roma 1999.
Perls, Hefferline & Goodman: “Teoria e pratica della Terapia della Gestalt“, Astrolabio, Roma, 1971
Perls F.S. La terapia gestaltica parola per parola, Astrolabio, Roma 1980.
Perls, F. (2003). L’io, la fame, l’aggressività. L’opera di uno psicoanalista eretico che vide in anticipo i limiti fondamentali dell’opera di Freud. FrancoAngeli.
Quattrini G. P., Fenomenologia dell’esperienza, Zephyro, 2007
Quattrini G. P., Per una psicoterapia fenomenologico esistenziale, Giunti, Firenze, 2011.
Venturini R., Ri-legature buddhiste, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2010.



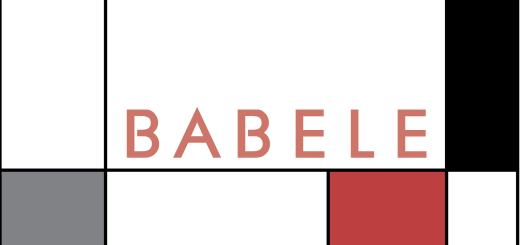

Commenti recenti