Psicoterapia della Gestalt e Mindfulness: un incontro felice
Abstract
Di Emanuele Gatti
Gestalt Counsellor e Istruttore Mindfulness
Pubblicato sul Numero 37 di Formazione IN Psicoterapia, Counselling, Fenomenologia
Il concetto di mindfulness
La parola “mindfulness” ha, sia in inglese sia in italiano, diversi significati. La traduzione più comunemente usata nei testi italiani è “consapevolezza”; sulle qualità di questa consapevolezza sono stati e continuano a essere scritti numerosi volumi. Questa proliferazione di testi non è tanto dovuta alla necessità di distinguere la mindfulness da una pletora di altri costrutti, nati nella più recente psicologia occidentale, che parzialmente vi si sovrappongono (come quelli di “mindedness”, “mind-set” o “mindsight”), quanto al fatto che il termine “mindfulness” fu originariamente usato per tradurre il concetto buddhista di sati (in Pali), ma tale traduzione risulta alquanto problematica1. Non solo il concetto di sati è fondamentale nel buddhismo e già di per sé di non facile comprensione, specialmente a chi non abbia una pratica continuativa di meditazione; esso, poi, ricorre continuamente sia negli scritti che riportano i discorsi del Buddha, sia nei commentari interpretativi di tali scritti, ma il buddhismo delle origini (Theravada) lo interpreta diversamente da come è stato poi compreso nel relativamente più recente buddhismo zen e in quello tibetano; nel buddhismo, inoltre, sati è solo una delle pratiche fondamentali del cammino verso l’illuminazione, mentre in Occidente viene spesso indicato (erroneamente, da un punto di vista pratico oltre che dottrinale) come l’unico elemento o comunque il più importante elemento per raggiungere determinati risultati sul piano del benessere fisico e psicologico; alcuni maestri buddhisti del XX secolo, infine, hanno interpretato il concetto di sati in maniera personale, e questi stessi maestri sono stati influenti nel determinarne la ricezione in Occidente. In altre parole, il termine sati, già di per sé ricco di significato e pressoché impossibile da comprendere pienamente su un piano puramente cognitivo (così come non si può comprendere, per esempio, l’amore senza esperirlo), già non è univoco nel pensiero buddhista, ed è stato quindi recepito in Occidente in un modo originale e talvolta decontestualizzato, che si discosta parzialmente dai significati originari ad esso attribuiti dalle diverse tradizioni buddhiste, pur conservandone alcuni elementi. In base a questa ricezione occidentale del termine, le definizioni di mindfulness date dai diversi autori ne enfatizzano ora la componente attentiva, ora quella di consapevolezza nel presente e del presente, in una forma spesso semplicistica rispetto a quanto viene fatto nel pensiero buddhista.
Una disanima del termine sati va oltre gli scopi del presente articolo (e ben oltre le mie conoscenze); mi limiterò a elencare alcuni dei significati del termine “mindfulness” in Occidente, senza entrare nei tecnicismi delle discussioni accademiche.
Il termine “mindfulness” è comunemente usato per indicare un insieme di tecniche meditative e di protocolli basati sulle pratiche di meditazione che sono conosciute in Occidente come Vipassana. È a questo senso che si farà riferimento in questo articolo. Questo uso deriva dal fatto che nel 1979 Jon Kabat-Zinn, un medico e un praticante assiduo di meditazione, strutturò un protocollo finalizzato a migliorare la condizione dei pazienti affetti da dolore cronico. Tale protocollo, definito Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), risultò particolarmente efficace e diede vita a una progressiva proliferazione di studi scientifici multidisciplinari, principalmente (ma non solo) atti a investigare l’effetto di varie tecniche di meditazione sulla salute psico-fisica di popolazioni cliniche e non. Le pratiche che compongono l’MBSR furono sviluppate primariamente nella tradizione buddhista, ma, come rilevato da numerosissimi autori, di fatto si ritrovano, mutatis mutandis, in diverse religioni e tradizioni mistiche mondiali. Come osservato da Kabat-Zinn, alla base della mindfulness vi sono certamente gli insegnamenti del Buddha, i quali però “non sono né una credenza, né un’ideologia, né una filosofia. Piuttosto, sono una descrizione fenomenologica coerente della natura della mente”2(ragione per la quale oggi negli ambienti scientifici si parla con rispetto di “psicologia buddhista”). L’incontro tra l’MBSR e la ricerca scientifica ha dato vita a una lista (ormai lunga) di protocolli orientati verso popolazioni specifiche, patologiche e non, che vengono oggi definiti collettivamente “interventi basati sulla mindfulness” (MBI: mindfulness-based interventions). Generalmente, la definizione di mindfulness cui tutta questa letteratura si rifà è quella proposta originariamente da Kabat-Zinn di consapevolezza che emerge dal prestare attenzione allo svolgersi dell’esperienza momento per momento, con intenzione, nel presente e in modo non giudicante3. Nel presente articolo mi riferirò a questa definizione quando parlerò di mindfulness, e userò l’espressione “interventi basati sulla mindfulness” per riferirmi alle tecniche e ai protocolli relativi (chiedo però al lettore di non dimenticare la ricchezza concettuale del termine “mindfulness”, ricchezza che si può cogliere pienamente solo attraverso una pratica costante, ancorché secolare, della meditazione, ma che si può iniziare ad assaporare già dopo qualche settimana di meditazione).
Forse proprio il successo dell’MBSR ha generato, specialmente negli ultimi 15 anni, un fenomeno del tutto simile a una moda intorno alla mindfulness, per cui di tale parola si è abusato, generando incomprensioni rispetto al suo significato. Partiamo dal mondo della psicologia.
Nella comunità degli psicologi vi è chi pensa che la mindfulness, intesa qui come intervento basato sulla mindfulness, sia una psicoterapia. Il dubbio è corroborato dal fatto che un altro celebre protocollo derivato dall’MBSR è chiamato Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)4. In realtà, tanto Kabat-Zinn rispetto all’MBSR quanto Segal, Williams e Teasdale, i creatori dell’MBCT, hanno più volte chiarito che tali protocolli non costituiscono una psicoterapia. Esistono tuttavia alcune psicoterapie che incorporano elementi di mindfulness, intesa qui più come sati che come MBI, quali l’Acceptance and Commitment Therapy di Hayes, la Dialectical Behavioral Therapy della Linehan e la Compassion-focused Therapy di Gilbert. Vi è inoltre un’ampia letteratura, specialmente anglosassone, sull’incorporazione delle tecniche di mindfulness nella pratica clinica, sebbene si corra il rischio di una concezione riduzionista della mindfulness a mera tecnica terapeutica da tradurre secondo un paradigma terapeutico preesistente 5.
A complicare ulteriormente la situazione, almeno nel mondo della psicologia accademica, sta il fatto che alcuni ricercatori considerano la mindfulness un tratto di personalità (si parla in questo caso di trait mindfulness o mindfulness disposizionale). Al di là del fatto che tuttora si discuta se tale tratto sia singolo o piuttosto costituito da un insieme di tratti separati, appare evidente che la mindfulness disposizionale, pur recando il nome “mindfulness”, non ha niente a che vedere con la mindfulness. Quest’ultima è, per definizione, uno stato, una modalità dell’essere, o se si vuole, una particolare modalità della coscienza, esperibile da chiunque perché naturalmente disponibile per l’essere umano. La mindfulness disposizionale è invece una supposta (non ancora dimostrata) predisposizione di taluni individui alla meditazione e allo stato mindful. L’una ha a che vedere con una modalità dell’essere allenabile attraverso il fare pratica, l’altra riguarda una particolare combinazione genetica. Personalmente non mi trovo contrario a che si esplori se alcune persone sono naturalmente predisposte alla meditazione: si tratta di un dubbio legittimo, soprattutto laddove si consideri che sono stati registrati nel mondo scientifico alcuni casi di grandi meditatori figli di grandi meditatori6. L’espressione mindfulness disposizionale, tuttavia, risulta particolarmente inadeguata, non solo per la confusione che ingenera (esisterebbero due mindfulness?), ma anche perché reifica la mindfulness, come se si trattasse di uno stato permanente disponibile solo per pochi, o di una qualità che o si ha o non si ha.
Passiamo ora al mondo della mindfulness pop, o, come la chiamano due esperti italiani di mindfulness, Fabio Giommi e Antonella Commellato, della pink mindfulness 7. Spesso il termine “mindfulness” è usato, impropriamente, come sinonimo di meditazione in generale, uso che ritroviamo nell’espressione “fare mindfulness”; oppure come sinonimo di “attento”, per cui “essere mindful” significherebbe semplicemente “stare attenti”; altre volte la mindfulness e l’“essere mindful” sono accostati a un particolare stile di vita, spesso proposto come in qualche misura salvifico. Si tratta di usi imprecisi, banalizzanti e spesso orientati alla vendita di prodotti e servizi che recano la “mindfulness” più nell’etichetta che nei contenuti. L’equivoco più grande, comunque, risiede nell’idea che la mindfulness sia una tecnica di rilassamento per raggiungere un qualche tipo di benessere psico-fisico (idea forse derivante dal concetto di riduzione dello stress): la prima cosa che si scopre applicandosi, per esempio, in un MBSR è che meditare fa male – nel senso che il corpo è obbligato a posizioni almeno scomode per i più e dolorose per molti, per periodi di tempo brevi se confrontati con quelli dei ritiri per i meditanti più esperti, eppure già tali da far emergere tensioni fisiche ed emozioni quali l’ansia, la paura e persino il panico, la noia. Il principio della mindfulness non è l’evitamento del negativo in favore di uno stato di benessere, quanto piuttosto lo stare con il negativo per imparare a disidentificarsi da esso. La meditazione, anche nelle dosi omeopatiche degli MBI, è dunque tutt’altro che rilassante.
Similmente, un accostamento preoccupante è quello tra mindfulness e felicità. Sono ormai decine i testi, di solito meramente divulgativi, ma talvolta anche autorevoli, che accostano nel proprio titolo questi due termini, suggerendo più o meno esplicitamente che la mindfulness è la via per la felicità. Se alla parola mindfulness si sostituisce “meditazione”, e se si è in un contesto buddhista, ciò è vero: per i buddhisti sati è uno dei mezzi per la felicità. Va tuttavia precisato, pur semplificando grossolanamente, che nel pensiero buddhista la felicità è concettualizzata come assenza di dolore (inteso qui in senso ampio), e non come piacere (eudonia) o realizzazione nella vita (eudaimonia), come più comunemente (ma non esclusivamente) è pensata in Occidente. Se, però, in un universo concettuale del tutto secolare, si accostano mindfulness e felicità, ecco che o si è colpevoli di riduzionismo, o ancor peggio si sta facendo pink mindfulness. Questo semplicemente perché la mindfulness porta certamente a una maggiore chiarezza e a uno stato emotivo più controllato, ma porta anche a vedere quel che c’è, e se quel che c’è è infelice, tutto quel che può fare è aiutare a sopportare quell’infelicità, accettandola e disidentificandosi da essa. Ne porta un’esemplare testimonianza Dario Girolami, Maestro Zen che da ormai 12 anni insegna meditazione ai detenuti del carcere di Rebibbia a Roma. Nel suo documentario La via interiore. Meditazione a Rebibbia, è mostrato come ai detenuti la meditazione arrechi grandi benefici, ma non riesca certo a portare la felicità.
Interventi basati sulla mindfulness e Gestalt
A uno sguardo distratto, gli interventi basati sulla mindfulness e la psicoterapia della Gestalt possono apparire pratiche distanti. Tali interventi, ovviamente, trovano facilmente posto nell’alveo delle tecniche cognitivo-comportamentali. I numerosi protocolli basati sulla mindfulness, tra i quali i più diffusi in ambito clinico, nonché i più noti anche al grande pubblico, sono certamente i già citati MBSR ed MBCT, ben si inseriscono in un approccio terapeutico che ha fatto delle procedure standardizzate, dei protocolli e dei manuali ad hoc per ogni possibile disturbo clinico il proprio punto di forza. L’MBSR e gli altri MBI richiedono una rigorosa aderenza alla strutturazione predefinita e standardizzata dei protocolli stessi, e gli insegnanti di MBSR in particolare sono formati a mantenersi strettamente entro i confini di tale strutturazione. Superficialmente, questi confini così ben definiti possono risultare oppressivi agli psicoterapeuti e ai counsellor della Gestalt, che godono invece di un’ampia discrezionalità nello svolgimento dei propri interventi. La Gestalt, tuttavia, ha sempre avuto la peculiarità di essere particolarmente atta a integrare tecniche sviluppate in altri approcci e persino, a volte, in altri mondi esperienziali, come testimonia il fecondo incontro tra Gestalt e arte. Noi gestaltisti siamo, spesso per natura, talvolta per formazione, inclini a una pratica clinica integrata che, anzi, rischia in alcuni casi di sfociare nell’eclettismo (leggi: in una pratica caotica, ricca e creativa ma poco consapevole) anziché nell’integrazionismo assimilativo (ovvero in una pratica ben solida nelle sue basi teoriche, ma capace di integrare poche altre tecniche, ben conosciute e su cui si costruisce una grande esperienza, generando così un metodo sì nuovo e personale, ma non slegato dalla teoria e dalla sua matrice originaria). Avvertiti di questo rischio, non ci stupirà, dunque, constatare che tanti gestaltisti includano tecniche di mindfulness nel proprio lavoro. Se, giova ripeterlo, ciò andrebbe fatto a partire da una profonda conoscenza, una chiara comprensione e una pratica costante della mindfulness, è anche vero che, nella pratica clinica, Gestalt e mindfulness si incontrano e si sposano felicemente.
Di seguito esporrò alcuni dei punti di contatto, spesso di sovrapposizione, tra Gestalt e interventi basati sulla mindfulness, senza alcuna pretesa né di esaustività né di sistematicità.
La relazione con la patologia
La Gestalt tendenzialmente rifiuta tanto l’idea di una normalità quanto, conseguentemente, quella di patologia, per lo meno intesa come etichetta che si applica sul paziente, determinando sia la sua relazione con se stesso, sia il modo di porsi del mondo, e del terapeuta, verso di lui. Pur riconoscendo che esistono modalità dell’essere comuni a tutti gli esseri umani (per esempio, le interruzioni di contatto), la Gestalt valorizza l’unicità degli individui. La Gestalt, inoltre, come altri orientamenti umanistici (si pensi a Frankl o a Rogers), nutre una piena fiducia nelle capacità delle persone e ne sostiene l’autonomia, invitando a una viepiù maggiore assunzione di responsabilità personale.
L’MBSR, essendo nato in un contesto ospedaliero con pazienti affetti da grandi sofferenze fisiche, riconosce pienamente il disagio delle persone, ma non per questo assume una visione indulgente, e anzi richiede ai partecipanti una solida presa di responsabilità a praticare, indipendentemente dalle proprie condizioni psico-fisiche. L’MBSR, inoltre, si è posto sin dall’inizio come transdiagnostico, ovvero rivolto alla popolazione in generale, sana o affetta da patologie conclamate. I successivi interventi derivati dall’MBSR sono spesso rivolti a popolazioni che soffrono di patologie specifiche (depressione maggiore, ansia, disturbi alimentari, dipendenza da sostanze), ma tali patologie non sono prese come etichette invalidanti, bensì come considerazioni di fatto che quelle persone necessitano di una diversa psicoeducazione. È infatti questa la parte che maggiormente viene modificata da un MBI all’altro, rimanendo la parte di pratica in buona misura la medesima per l’MBSR e per gli altri MBI (e in particolare per l’MBCT)8.
La sospensione del giudizio
Nella consapevolezza che la Gestalt ha come sfondo la filosofia occidentale (con una spruzzata di Oriente derivante dal periodo giapponese di Perls e dalle influenze orientaleggianti che dovevano aver raggiunto Esalen negli anni Sessanta e Settanta), mentre la mindfulness ha come sfondo la filosofia e la psicologia buddhiste, la prima similitudine è che entrambe invitano a uno sguardo essenzialmente fenomenologico sul mondo, ovvero a una percezione dell’esperienza così come essa si presenta, senza il filtro di preconcetti e pregiudizi – ciò che, sia nella Gestalt sia nella mindfulness, è comunemente riassunto dall’espressione “essere non-giudicanti”. Il giudizio, dunque, non è qui inteso come attività normativa, bensì come prospettiva personale che impedisce di cogliere il fenomeno così come esso si presenta. La sospensione del giudizio non è moralistica, ma da intendersi come una sospensione (alquanto temporanea per la maggior parte dei comuni mortali) della visione che già abbiamo di come una realtà dovrebbe essere, e che si frappone tra il nostro occhio e la realtà come effettivamente è. Si tratta di entrare in relazione con i fenomeni, così come vissuti dal soggetto, senza imporvi delle concettualizzazioni, delle classificazioni o dei giudizi di valore tramite modelli interpretativi. È vero che a volte ci innamoriamo di una particolare idea della realtà, oppure ci rifiutiamo di incontrare una realtà che non ci aggrada, ma in questo modo, tanto per la Gestalt quanto per la mindfulness, non evitiamo di incontrare la sofferenza – semplicemente ci voltiamo altrove, con la sofferenza che resta lì, a premere, come un bisogno psichico non atteso. La nostra mente è altresì soddisfatta quando riesce a darsi una spiegazione dei fenomeni, ma ogni spiegazione non è che un’astrazione a partire da un più o meno consapevole modello o schema interiore, una sovrastruttura applicata a una realtà che invece semplicemente è quel che è. La sospensione del giudizio implica lo scoraggiamento di questo meccanismo naturale della nostra mente, a favore di un’osservazione e di una descrizione dei fenomeni così come essi si dispiegano di fronte ai nostri occhi – occhi che non sono necessariamente ingenui, come si afferma spesso attraverso la note metafore, a mio parere semplicistiche, dello sguardo del bambino o dello sguardo del principiante, ma che rimangono capaci di esplorare quanto appare già noto, di interrogarsi su quanto a prima vista sembra ovvio.
Nella relazione d’aiuto gestatica, la sospensione del giudizio è necessaria per il professionista, per sostenere una sana relazione con il cliente all’interno della quale questi si senta visto per quel che è e rispettato per il suo essere tale, e va incoraggiata e sostenuta nel cliente, affinché egli la eserciti a sua volta su di sé e nelle circostanze della vita. In accordo a entrambe le tradizioni, questa attitudine non-giudicante può essere sviluppata attraverso la pratica. Nella Gestalt l’attitudine non-giudicante si declina sic et simpliciter nel ritrarsi dalle interpretazioni che inevitabilmente emergono durante l’incontro con l’altro, prestandosi invece a investigare quel che spesso si dà per scontato, per facilmente immaginato. Nell’MBSR, un simile processo di investigazione è parte del protocollo e si chiama inquiry. Non si tratta di un processo naif: esso ha piuttosto una funzione maieutica, nel senso che mira a consentire al partecipante del protocollo di aumentare progressivamente la profondità della propria consapevolezza riguardo alla sua stessa esperienza – così come avviene nella relazione terapeutica, ma prestando attenzione al fatto che il contesto di un MBSR non è psicoterapeutico. Allo stesso tempo, l’inquiry è effettuata a partire da una curiosità che è resa possibile solo dal non avere già le risposte dentro di sé, o meglio, dal sospenderne la cogenza. Le esperienze portate dai partecipanti, infatti, si ripeteranno invariabilmente e inevitabilmente da un protocollo all’altro, e l’istruttore le conoscerà benissimo, anche per averle vissute in parte egli stesso durante la propria formazione. Come nella Gestalt, però, non è tanto il contenuto dell’esperienza del soggetto a essere rilevante, quanto il modo specifico in cui quella persona vive quell’esperienza. L’istruttore di mindfulness si sentirà ripetere ancora e ancora che il dolore alle gambe ha impedito la meditazione, così come il terapeuta si sentirà raccontare storie sostanzialmente simili da clienti diversi, ma per entrambi non sarà tanto importante il contenuto dell’esperienza, bensì come la persona si rapporta a essa.
Se è vero che l’inquiry non deve scivolare in una relazione terapeutica, lo è anche che l’essere addestrati a condurre tale relazione, specialmente secondo un modello umanistico, non-deterministico, aiuta la conduzione dell’inquiry. L’inquiry, infatti, come la psicoterapia e il counselling della Gestalt, si configura più come un’arte che come una tecnica o l’applicazione di un metodo. Proprio come in Gestalt, è opportuno che il conduttore di un MBI si lasci orientare dalle emozioni proprie e degli interlocutori. Nella Gestalt si invitano comunemente i professionisti all’uso di due facoltà dell’intelligenza emotiva: l’empatia, certamente, intesa come capacità di sentire o almeno di capire quel che l’altro prova, e la ancor più importante simpatia, intesa invece come la capacità di riconoscere quel che proviamo in risposta ai fenomeni ovvero, nella relazione di aiuto, al comportamento dell’altro e a quel che egli ci porta.
Tanto nella Gestalt quanto negli MBI, inoltre, vi è la necessità, sia per il professionista, sia per il paziente o il partecipante al gruppo, di portare l’attenzione a se stessi, osservando i segnali corporei. Questa attenzione implica un’accettazione dei segnali stessi, sebbene non necessariamente un loro gradimento, perché il semplice fatto di mantenere l’attenzione su un fenomeno implica la disponibilità a entrarvi in relazione, qualunque sia la sua natura. Parimenti, come nella Gestalt spesso si usano tecniche, come quella delle due sedie, volte a sostenere la disidentificazione del paziente da un suo particolare vissuto, allo stesso modo la mindfulness, attraverso la pratica, promuove la disidentificazione dai propri vissuti interiori e corporei.
Ecco allora che la pratica della mindfulness può sostenere tanto il professionista gestaltico, intensificando la sua capacità di sostenere una relazione non-giudicante e sostanzialmente accettante, quanto il cliente, anche quello avulso da ogni pratica di meditazione, attraverso la proposta estemporanea di tecniche isolate di mindfulness, o preferibilmente attraverso l’incorporazione, nel percorso di aiuto, di ripetuti esercizi di tipo meditativo volti a sostenere il contatto con un vissuto. Meglio ancora, il cliente può affiancare un MBI al percorso personale con il professionista gestaltico, utilizzando il primo come uno spazio di esplorazione primariamente non cognitivo, e il secondo come spazio esperienziale maggiormente guidato da un’analisi cognitiva dei vissuti corporei e mentali. Si tratta di due modalità diverse che ben si integrano e sostengono a vicenda.
La relazione con l’esperienza
Un’altra similitudine nella Gestalt e nella mindfulness sta nel fatto che entrambe sono guidate dall’esperienza più che da un’aspettativa teorica. A differenza della psicodinamica e del cognitivismo-comportamentismo, che sono essenzialmente deterministici, nel senso che la loro teoria precede e guida l’esperienza con il cliente, per la Gestalt, pur non priva di un impianto teorico, è l’esperienza con il cliente e del cliente a consentire la nascita di una teoria sullo stesso. Nella Gestalt vi è il primato dell’esperienza diretta, immediata, e lo stesso avviene con la mindfulness. Certamente, la strutturazione in protocollo della pratica meditativa può apparire come massimamente deterministica, ma di fatto la proposta standardizzata di una serie di esercizi non ne riduce la dimensione esperienziale sostanzialmente soggettiva, dimensione alla quale il conduttore del protocollo darà particolare enfasi e valore proprio attraverso l’inquiry. I protocolli, inoltre, si basano per l’80-90% del tempo sulla pratica personale, e la pratica è l’esperienza.
A un livello più astratto, affermare il primato dell’esperienza implica riconoscere che l’esperienza in sé è fondamentale, non la sua traduzione in termini cognitivi. Per la Gestalt, non è tanto importante spiegare l’esperienza, quanto il promuovere la presa di contatto con essa, cioè l’esperire l’esperienza così come essa è. Ovviamente, una relazione di aiuto di counselling o terapeutica passa inevitabilmente per un’ampia attività di tipo discorsivo-cognitivo, che va oltre i confini della seduta. In questa attività, tuttavia, le interpretazioni sono scoraggiate, gli introietti messi in discussione, le visioni acritiche criticate, al fine di liberare il campo alla sospensione del giudizio. Si ritiene, inoltre, che non sia questa attività discorsivo-cognitiva a provocare il cambiamento, bensì la possibilità, che essa aiuta a concretizzarsi, che il paziente faccia qualcosa di diverso dagli schemi di reazione abituali, ovvero un’esperienza nuova, capace di allargare il suo ventaglio di scelte comportamentali e di risposte emotive. La Gestalt è indubbiamente un approccio che promuove il sentire, ma non lo fa dando al sentire un primato ontologico, come se si trattasse di uno scopo in sé, bensì in funzione del contatto diretto con l’esperienza, ovvero dell’aumento della consapevolezza. In questo senso è paragonabile alla mindfulness, la quale “pone il primato ontologico della consapevolezza: per cui è possibile osservare, nel « qui e ora », le nostre sensazioni-emozioni da un « luogo » che non coincide con quelle sensazioni-emozioni”9.
Il focus sul presente
Tanto nella Gestalt quanto nella mindfulness si enfatizza l’importanza di portare l’attenzione al momento presente. Per la prospettiva teorica da cui la mindfulness deriva, il passato e il futuro semplicemente non sono, solo il presente è: passato e futuro possono solo essere pensati, e dunque sono esperienze di proiezione mentale che avvengono pur sempre nel presente. Per la Gestalt il passato e il futuro esistono e ci condizionano, ma non sono i tempi in cui si può operare. L’attenzione va dunque portata al presente, il quale, tuttavia, rimane incerto: mentre il passato è (o quantomeno appare) certo, e il futuro può essere solo immaginato, il presente è quel che è, ma non è prevedibile perché già è. Il presente può quindi rivelarsi sorprendente, e una sua esplorazione non è un atto scontato, perché in continuo mutamento: è il divenire del presente, il suo spiegarsi davanti ai nostri occhi a renderlo incerto e dunque un potenziale oggetto del nostro interesse.
Dalla necessità di stare nel presente a dalla sospensione del giudizio consegue l’importanza di accettare di poter stare nell’incertezza, nel non sapere. Questo è vero per il praticante di mindfulness; per il professionista gestaltico che non sa del suo cliente e proprio per questo è in grado di vederlo; per il cliente della relazione di aiuto, il quale, man mano che questa si dipana, abbandona i vecchi schemi di reazione ed entra in un’area di oscurità, di anomia, di spaventosa incertezza in cui nuove modalità dell’esperire devono ancora formarsi.
Conclusioni
Con questo articolo ho inteso mostrare come la Gestalt e la mindfulness condividano alcune premesse ontologiche ed epistemologiche, che ne favoriscono l’incontro e l’integrazione. Lascio la parola a persone più esperte di me in ambito clinico sul come questo incontro si possa concretizzare. Per esperienza, mi sento tuttavia di avvisare il professionista che la mindfulness diviene sterile e poco utile, sia per il terapeuta, sia per il cliente, quando è proposta come mera tecnica – per esempio invitando il cliente a focalizzarsi per 10 minuti sul respiro. L’esperienza può piacere e nutrire sul momento, ma rischia di restare poco più che un gioco se non è sostenuta quanto meno da un’interiorizzazione, da parte del terapeuta, dei principi della mindfulness stessa, che vada a colorire l’intera relazione terapeutica.
1 Rimando per un approfondimento a: Bodhi, Bhikkhu (2013), “What does mindfulness really mean? A canonical perspective”, in J. Mark G. Williams e Jon Kabat-Zinn (a cura di), Mindfulness. Diverse Perspectives on its Meaning, Origins and Applications, Oxon: Routdledge, 19-39. Gethin, Rupert (2015), “Buddhist Conceptualizations of Mindfulness”, in Kirk Warren Brown; David Creswell, J. e Richard M. Ryan (a cura di), Handbook of Mindfulness. Theory, Research, and Practice, New York: The Guilford Press, 9-41.
2 Kabat-Zinn, Jon (2003), “Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present and Future”, Clinical Psychology: Science and Practice, vol. 10, n° 2: 144-156; citaz. a p. 145 (corsivo mio).
3 Kabat-Zinn, Jon (2013), Full Catastrophe Living (Revised and Updated Edition), New York: Bantam Books.
4 Segal, Zindel V.; Williams, J. Mark G. e Teasdale, John D. (2012), Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression (2^ ed.), New York: The Guilford Press.
5 Giommi, Fabio (2014), “Introduzione”, in Segal, Zindel V.; Williams, J. Mark G. e Teasdale, John D., Mindfulness. Al di là del pensiero, attraverso il pensiero, Torino: Bollati Boringhieri.
6 Cfr. Davidson, Richard J. e Begley, Sharon (2012) The Emotional Life of Your Brain, New York: Hudson Street Press.
7 Conversazione personale. Vd. anche Giommi, Fabio, cit., cui parzialmente mi rifaccio per questo paragrafo.




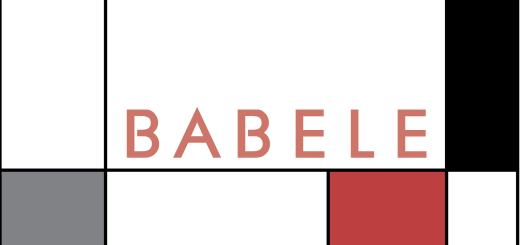
Commenti recenti